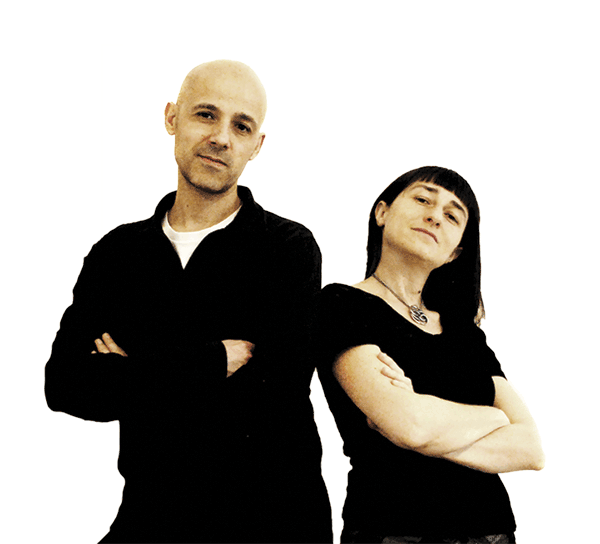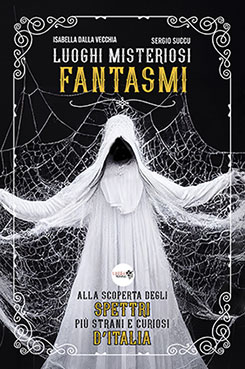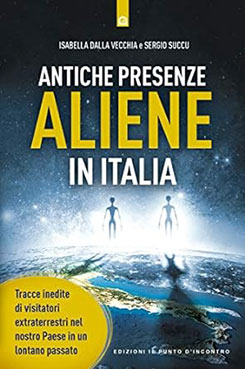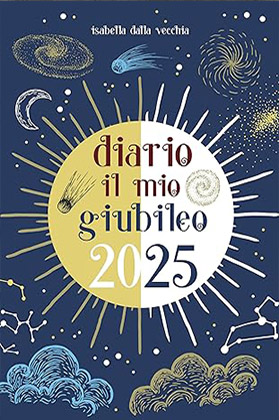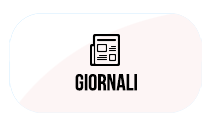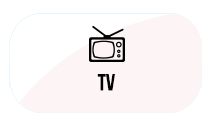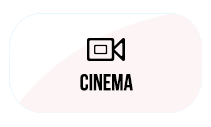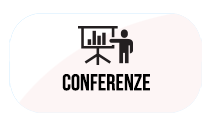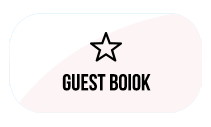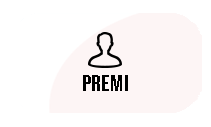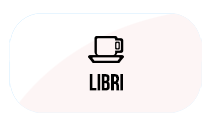![]() SICILIA / Piazza Santo Carcere 7, 95124 Catania CT, Catania / Scavi e ritrovamenti confermano la presenza nel territorio di elefanti nani, i cui particolari crani avrebbero dato origine alle leggende di ciclopi
SICILIA / Piazza Santo Carcere 7, 95124 Catania CT, Catania / Scavi e ritrovamenti confermano la presenza nel territorio di elefanti nani, i cui particolari crani avrebbero dato origine alle leggende di ciclopi

FEDERICO II DI SVEVIA E GLI ENIGMATICI SIMBOLI DEL PORTICO DELLA CHIESA DI S. AGATA AL CARCERE DI CATANIA
ARTICOLO DI GIANCARLO BURGIO E FOTOGRAFIE DI ROBERTO BURGIO
__________________________
CATEGORIE
![]() Alchimia / Alchimisti
Alchimia / Alchimisti
![]() Animali / elefante
Animali / elefante
![]() Animali mitologici / ciclope
Animali mitologici / ciclope
![]() Fenomeni naturali / Vulcani
Fenomeni naturali / Vulcani
![]() Giganti
Giganti
![]() Leggende
Leggende
![]() Personaggi / Federico II
Personaggi / Federico II
Il duecentesco portale della Chiesa di S. Agata al Carcere a Catania, voluto dall’Imperatore Federico II a ricordo della soffocata rivolta della città etnea, presenta simboli e sculture i cui significati sono ancora avvolti dal mistero nonostante nei secoli a noi più vicini diversi studiosi abbiano cercato di interpretarli. Con l’aiuto degli ingrandimenti fotografici, per di più, si notano particolari che tendono a smentire quanto già proposto in passato.
Nel Duomo di Catania esattamente di fronte la cappella dedicata alla S. Patrona Agata, vi è il più sontuoso monumento funebre marmoreo della Cattedrale, appartenente al Rev.mo Monsignor Pietro Galletti.
Nato a S. Cataldo (Cl) il 27 ottobre 1664 fu vescovo di Catania dal 1729 al 1757 anno in cui morì all’età di 93 anni. Molteplici sono le opere da attribuire a lui durante il suo vescovato.
In Via Crociferi fece costruire la Chiesa di San Camillo dei PP Crociferi, e quella di San Francesco Borgia dei Gesuiti. In entrambe le chiese si trovano due lapidi a lui dedicate.
Sempre edificati dal Galletti furono sia il prospetto in marmo del Duomo sotto la direzione del geniale ingegnere G. B. Vaccarini, sia al suo interno la valorizzazione dei pregevoli dipinti scampati al terremoto del 1693, arricchendoli con superbe cornici dorate in oro zecchino. A proprie spese rieresse ed ornò l’archivio della gran corte arcivescovile distrutto sempre dal funereo cataclisma che colpì Catania e tutta la Val di Noto alla fine del XVII secolo.
Proprio per il rifacimento della facciata del Duomo si rese necessario trasferire il portale dell’antica cattedrale rimasto fortunosamente integro dopo il crollo del campanile che si abbatté soltanto nel corpo centrale della vecchia basilica. Il Galletti quindi lo fece rimuovere in un primo tempo nel 1734 ponendolo all’ingresso dell’antica Casa Municipale per poi passare definitivamente nel 1762 come portale della Chiesa del S. Carcere (cfr. Mons. Romeo: Sant’Agata V. M. e il suo culto).
Il portale, di notevole importanza storica, segue lo stile architettonico siciliano dell’XI secolo. Difatti oltre ad essere un raro avanzo dell’arte medievale in Catania, esso racchiude in tutti i suoi simboli una pagina di storia cittadina riguardante l’epoca della sua costruzione.
Fu fatto eseguire da Federico II svevo intorno al 1236 (più di 140 anni dopo la costruzione del tempio edificato da Ruggero nel 1094), nel tempo in cui erano note le lotte interne tra Federico ed il Papa Gregorio IX. Molte città anche siciliane si schierarono per l’uno o per l’altro fronte, e Catania si strinse attorno al proprio vescovo Gualtiero, persona altamente carismatica ed influente su tutta la cittadinanza anche per la sua stretta vicinanza al Papa. Nello stesso tempo Federico revocò diversi presunti privilegi concessi dai precedenti sovrani alla città di Messina, con la scusa di essere incompatibili con il suo concetto di “stato autoritario”. Ciò fece scoppiare nel 1232 una rivolta in diverse città siciliane che lo stesso regnante dovette domare nel sangue. Dopo Messina portò la distruzione a Centuripe mentre Siracusa e Catania si limitarono alla resa. La storia racconta che per sottoscrivere tale resa l’imperatore inviò in città degli ambasciatori che furono respinti in un primo tempo. Successivamente entrati gli Svevi a Catania e messa in fuga la popolazione intera, si diressero verso la cattedrale dove nel frattempo si erano rifugiati gran parte dei comandanti.
Tradizione vuole che Federico, dopo aver emanato l’ordine di condanna a morte di questi, volle di persona entrare nel sacro tempio e aperto un messale vide apparire a lettere di fuoco la nota frase: “NOLI OFFENDERE PATRIAM AGATHAE QUIA ULTRIX INIURIARUM EST” (non offendere la patria di Agata, perché è vendicatrice delle ingiurie che ad essa si fanno). Frase senz’altro forte e intimidatoria quasi da non attribuirsi alla “volontà di una santa” (a me cara !), ma che può trovare ragione nella decisione di Federico II di commutare la pena corporale e luttuosa da infliggere ai catanesi, in una pena non meno severa della prima, quale quella dell’umiliazione e del pentimento. Mettere in ginocchio una delle più importanti città della Sicilia, voleva significare inferire un grosso colpo non solo alle città ribelli ma anche alla figura più emblematica per Catania e per il Papa stesso, cioè il vescovo.
Difatti fu immediato l’ordine impartito dall’imperatore sia della costruzione di un castello maestoso ed imponente (Ursino) distante ma di fronte la Cattedrale, e sia di scolpire una serie di figure emblematiche che servissero da monito ai Catanesi ed ai viandanti, figure da collocare proprio all’ingresso della Cattedrale-fortezza di Catania.
Si deve al Prof. Musumeci l’interpretazione dei simboli posti su di essa. Il Prof. M. Musumeci, dotto archeologo e conoscitore del simbolismo medievale sostenne che il portale con i suoi simboli fu costruito nel 1241 da un “vescovo intruso”, un certo Enrico di Palimberga, proprio per adulare l’Imperatore Federico II. Quanto sotto descritto è tratto da “Monumenti di S. Agata esistenti in Catania” dello Sciuto Patti (1892). Il portale costruito in marmo bianco di Carrara è formato da archi concentrici e da esili colonnine, ma ciò che colpisce di più sono le rappresentazioni simboliche che danno un chiaro quadro dell’evento storico sopracitato.
Sopra la prima colonna a sinistra vi è rappresentato l’Imperatore seduto comodamente sul suo trono che con la mano destra si liscia la barba, anziché impugnare la spada o lo scettro, come simbolo di superbia e di prestigio. Per contrapposizione sulla prima colonna di destra il pezzo scolpito, almeno come scritto dal Musumeci, più non esiste essendo il pezzo scomparso con il terremoto del 1818. Un’accurata descrizione del portale (e quindi anche della figura mancante) ci viene dal Guarneri in “Le Zolle Historiche Catanee” del 1640, quando il portale era situato ancora nel Duomo.
Questa figura era composta da una dama ginocchioni e umile, con le chiome disciolte all’indietro (rappresentante Catania) che sostiene tra le sue braccia un toro e sul dorso di questo un irco (o ariete), entrambi con le corna non rotte ma ritorte all’indietro. Continuando a destra sulla seconda colonna si nota un uccello strozzato che è l’aquila unicipite, emblema della casata normanna. Accanto all’imperatore seduto, sulla seconda colonna di sinistra vi è l’Idra a molti capi, con il petto a terra e sempre strozzata. Questa rappresenta tutte le città siciliane che come Catania vennero placate da Federico. Nel terzo arco, a sovrastare le colonne vi sono altre due allegorie: la prima a sinistra è una scimmia con una palla in bocca a rappresentare l’uomo che non raggiunge il proprio intento, testimoniato anche dal globo non inghiottito simbolo del potere mai raggiunto. Di contro alla scimmia è rappresentata, per come descritta sempre dal Guarneri e dal Musumeci, una volpe seduta con i piedi tronchi e con il capo mozzo. Sempre il Musumeci in questa crede di riconoscere la depressione e l’annichilimento degli ordini monastici mendicanti. Ed è sempre dello stesso autore l’interpretazione delle due figure quasi speculari, che sovrastano i pilastri delle due ante della porta. Si tratta di un’Orsa che tiene fra le unghie il proprio parto in atto di offrirlo all’imperatore.
A vedere il portale oggi si nota come alcune figure non si trovino al posto descritto dal Guarneri e dopo dal Musumeci, forse o per errore di descrizione oppure perché scambiate al momento del trasporto dell’intero portale.
Altri piccoli particolari si notano ben evidenti come la pietra a forma di testa d’uccello posta sull’Idra, frammento questo proveniente chissà da dove o inserito chissà da chi, avvallato dal fatto che la descrizione del 1640 parla dell’Idra come uccello proprio mozzo di testa. Anche l’aquila normanna pare che sia il vero simbolo mancante descritto dal Musumeci, al contrario della dama in ginocchio con il toro in braccio che è tranquillamente posizionata sul primo capitello di destra ed è mancante solo del capo.
Per le due figure poste sopra le ante (l’Orsa) è evidente come soprattutto quella di sinistra rappresenti più un leone dalla possente criniera che addenta una lepre mentre con la zampa trattiene la preda. Forse la forza dell’Imperatore che vuole tenere tra le sue fauci per il collo una città ormai in suo potere. E per ultimo mi piace attirare l’attenzione sul rilassamento con cui è seduto Federico II sul suo trono ben vistoso, quasi a volersi godere il suo momento di gloria, e su di uno splendido ricamo lungo tutto il suo mantello che il tempo ci ha voluto consegnare così come ha fatto per tutto l’intero corpo architettonico.
Come conclude Mons. Romeo in un paragrafo a p. 247 della sua opera “…speciosa era quell’età, in cui, chi più sapeva trattare di quei simboli, più era tenuto in conto. Era il secolo di Dante, e i simboli, che il poeta creò, non sono anche oggi indegni della nostra ammirazione.”
Libro dell’autore:
Bibliografia.
G. Rasà Napoli – Guida alle Chiese di Catania – Palermo, 1984 (p. 42; p. 266).
G. B. Guarneri – Le Zolle Historiche Cataneee – Catania, 1640 (pp. 270-272).
Sciuto Patti – Monumenti di S. Agata esistenti in Catania (pp. 165-167).
S. Romeo – S. Agata V. M. e il suo culto – Catania, 1922 (pp. 245-247).
M. Musumeci – Opere archeologiche ed artistiche (pp. 119 e sgg.).
D. Mack Smith – Storia della Sicilia medievale e moderna (p. 73).
Nota. Le foto del portale sono di Roberto Burgio.


.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)